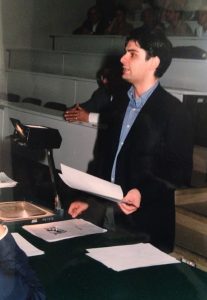L’argomento dei cambiamenti climatici ha ormai assunto proporzioni quasi ossessive nel dibattito pubblico e, come tutte le degenerazioni, si presta a strumentalizzazioni da parte di chi cerca di trarre profitto, approfittando dell’ignoranza diffusa sull’argomento, anche tra presunti esperti.
Con un po’ di ironia e un pizzico di sarcasmo mi piace identificare tre tipologie di approccio a questo argomento: quello del “lobbista”, quello del “complottista” e quello del “saggio”. Il “lobbista” si divide ulteriormente in due categorie: il “lobbista potente” e il “lobbista sfigato”
Il “lobbista potente” opera principalmente, anche se non esclusivamente, nei settori della manifattura di componentistica per impianti di produzione di energia rinnovabile, batterie di accumulo e centrali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta di una lobby molto potente, che muove enormi risorse finanziarie. La loro propaganda è basata sulla necessità assoluta di ridurre l’uso delle fonti fossili, che, secondo loro, sono l’unica fonte di emissioni di gas climalteranti, per evitare che fra qualche anno la Terra venga sconvolta da un “Armageddon” causato dagli incipienti sconvolgimenti climatici dovuti all’aumento della temperatura media globale.
Il gas climalterante per eccellenza è l’anidride carbonica (CO₂), prodotta, insieme al vapore acqueo (H₂O), nei processi di combustione. Altri gas climalteranti sono: il metano (CH₄), che proviene, ad esempio, dalle discariche o dalle attività agricole come allevamenti o risaie; il protossido di azoto (N₂O), che deriva dall’uso di fertilizzanti azotati in agricoltura e dai processi di decomposizione della materia organica nella gestione delle acque reflue e dei rifiuti; gli idrofluorocarburi (HFC), utilizzati come refrigeranti, propellenti e solventi, che hanno comunque un impatto significativo sull’effetto serra, seppur minore rispetto ai clorofluorocarburi (CFC), attualmente sostituiti; i perfluorocarburi (PFC), prodotti nella lavorazione dell’alluminio e nella produzione di semiconduttori; l’esafluoruro di zolfo (SF₆), utilizzato come isolante elettrico nei trasformatori e nelle apparecchiature elettroniche; i già menzionati clorofluorocarburi (CFC), ora progressivamente eliminati con il Protocollo di Montreal per il loro effetto dannoso sull’ozono e il loro forte contributo al riscaldamento globale; e l’ozono troposferico (O₃), che, sebbene non venga emesso direttamente, si forma a partire da reazioni chimiche tra altri inquinanti (ossidi di azoto e composti organici volatili) e agisce come gas serra a livello del suolo.
Il vapore acqueo merita un commento, perché non tutti sanno che è un potente agente climalterante e il suo effetto si autoamplifica: l’aumento della temperatura provoca maggiore evaporazione dell’acqua, che a sua volta amplifica l’effetto serra, facendo ulteriormente aumentare la temperatura e causando ancora più evaporazione. L’accumulo di vapore acqueo nell’atmosfera, causato dall’incremento delle temperature, è una delle cause delle piogge intense e delle inondazioni, la cui frequenza è in aumento.
Se è vero che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica è un obiettivo sensato, sia dal punto di vista ambientale che da quello tecnico, perché significa utilizzare meno combustibili e quindi sfruttare meglio le risorse naturali, è grossolanamente errato pensare di risolvere il problema dei cambiamenti climatici riducendo solo localmente le emissioni di gas climalteranti, infatti, la CO₂ e altri gas serra si accumulano nell’atmosfera e si distribuiscono uniformemente intorno al pianeta, indipendentemente da dove vengono emessi. Anche se l’Europa riducesse le proprie emissioni a zero, se le altre grandi economie, come ad esempio la Cina e l’India continuassero a emettere quantità crescenti di gas serra, la concentrazione globale di CO₂ continuerebbe ad aumentare. A tal proposito, è illuminante leggere i dati del report sulle emissioni di tutto il mondo prodotto annualmente dal Joint Research Centre (JRC) dell’Unione Europea. Il “GHG emissions of all world countries – JRC/IEA 2023 Report” evidenzia che nel 2023, rispetto al 2022, l’Europa a 27 ha ridotto le emissioni globali del 7%, gli Stati Uniti dell’1%, mentre la Cina le ha aumentate del 5% e l’India del 6%. Complessivamente, il mondo ha incrementato le sue emissioni del 2% rispetto al 2022 e del 62% rispetto al 1990. È quindi evidente che un approccio basato su riduzioni localizzate, nelle aree occidentali, non può bilanciare le emissioni globali, principalmente dovute alle regioni orientali del mondo, dove le tematiche ambientali sono subordinate agli interessi economici degli Stati.
Nella propaganda dei “lobbisti potenti”, troviamo i “lobbisti sfigati”, che cercano di sfruttare l’isteria sul cambiamento climatico per trarre piccoli benefici d’immagine, funzionali a limitati vantaggi commerciali o politici. Sono in pratica la manovalanza inconsapevole dei lobbisti potenti, amplificando la loro propaganda per obiettivi ben più grandi. Si tratta, ad esempio, degli esperti di greenwashing, una strategia di marketing utilizzata per dare l’impressione ingannevole di essere ecologicamente sostenibili per attrarre consumatori o elettori sensibili alle tematiche ecologiche. In realtà, le loro azioni o politiche spesso non corrispondono alle dichiarazioni.
Ad esempio non possono definirsi “eco”, un SUV che pesa tre tonnellate, una bottiglia di plastica o la busta della spesa spacciata per “biodegradabile” in una zona dove non vi sono impianti capaci di “biodegradarla”, un opera pubblica che preveda la piantumazione di qualche alberello, la creazione di una pista ciclabile o l’installazione di un piccolo impianto fotovoltaico ma che utilizzi materiali tradizionali senza una valutazione della effettiva “carbon footprint” ossia del bilancio complessivo del carbonio dell’intero progetto. È un modo poco corretto per manipolare il cittadino comune, che ignora gli aspetti tecnici e scientifici coinvolti.
Il “Complottista”, ossia il negazionista del cambiamento climatico, è un personaggio pittoresco, con sfaccettature variegate, che spaziano dal fondamentalismo dei terrapiattisti, alla pseudo scientificità dei negazionisti dell’allunaggio, per finire al cospirazionismo dei teorici del “Nuovo Ordine Mondiale”. Le loro tipiche frasi sono: “non vi è alcun motivo di allarmarsi, ci sono sempre state le estati calde”, “è il normale ciclo del Sole”, “le catastrofi naturali sono sempre esistite, non è colpa del clima”, “Gli allarmisti climatici vogliono solo controllare le nostre vite”, “Le emissioni di CO₂ fanno bene alle piante, quindi sono utili!”, “Ci sono state epoche glaciali e periodi caldi ben prima dell’uomo.”, “Il cambiamento climatico è solo una scusa per aumentare le tasse.”
I complottisti sono persone che si informano principalmente su internet navigando tra siti che sfruttano la loro limitata cultura per trarre profitti economici. Sono, in fondo, anch’essi manovalanza inconsapevole dell’altra potente lobby, quella dei combustibili fossili.
L’approccio “saggio” riconosce che i lobbisti, essendo orientati alla tutela di interessi economici di parte non possono generare una visione utile per la collettività. Riconosce inoltre che l’approccio complottista non ha alcun fondamento scientifico.
Il “saggio” prende atto che dall’inizio degli anni Settanta c’è una tendenza anomala all’aumento della temperatura media globale, che i ghiacci si stanno sciogliendo e gli eventi meteorologici estremi sono in crescita. Riconosce che nonostante i numerosi indizi, la responsabilità antropica dei cambiamenti climatici non è ancora provata univocamente, ma si rende conto che, anche se i cambiamenti climatici fossero causati dall’uomo, ci vorrebbero decenni per tornare ai livelli precedenti e questo non fermerà immediatamente gli eventi estremi. Si rende conto, che la riduzione delle emissioni di gas climalteranti limitata al mondo occidentale non compensa gli incrementi del mondo orientale, e principalmente Cina ed India, per cui il livello di gas serra globalmente aumenta. Riconosce che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica è positiva perché significa migliorare il rendimento dei processi industriali e, quindi, ridurre il consumo delle risorse naturali, ma si rende anche contro che tali interventi sono costosi e richiedono l’utilizzo di materie prime e prodotti provenienti dalle principali economie orientali e che una gestione inappropriata di questi processi può generare squilibri geopolitici e tensioni sociali interne ai singoli stati per l’impatto microeconomico che queste misure possono generare su imprese e famiglie.
La naturale conseguenza dell’approccio saggio è che insieme con gli investimenti tendenti alla riduzione delle emissioni di gas serra, bisogna investire nella realizzazione di adeguate opere di mitigazione degli effetti degli eventi estremi e di adattamento ai cambiamenti climatici, per smettere di dover piangere morti e stanziare fondi per la ricostruzione delle aree interessate da alluvioni e inondazioni. Il Dr. Jason Ur dell’Università di Harvard, citato anche nell’articolo di Emily Sohn “Climate change and the rise and fall of civilizations” pubblicato nella sezione web del sito della NASA dedicato ai cambiamenti climatici, riportando il risultato dei suoi studi, dice: “When we excavate the remains of past civilizations, we rarely find any evidence that they made any attempts to adapt in the face of a changing climate. I view this inflexibility as the real reason for collapse.” Ossia, in tutte le civiltà che si sono estinte in passato, non si rileva alcun tentativo di adeguarsi ai cambiamenti climatici, che è stata quindi una delle cause della loro caduta. La civiltà egizia, ad esempio, crollò durante una prolungata siccità 4.200 anni fa, così come quella dei Maya intorno al 900 d.C. La scomparsa della spettacolare città cambogiana di Angkor nei primi anni del 1400 è avvenuta per l’effetto combinato dei cambiamenti climatici accoppiati al degrado ambientale dovuto alla deforestazione e all’erosione del suolo. L’incapacità di adattarsi ai periodi di prolungata siccità alternati a forti alluvioni avvenuti verso la fine del XIV secolo hanno destabilizzato la stabilità economica e l’agricoltura, che erano fondamentali per il sostentamento della popolazione contribuendo alla sua scomparsa. L’adattamento ai cambiamenti climatici, quindi, è anche un modo per preservare le nostre civiltà.
La transizione energetica e i cambiamenti climatici rappresentano opportunità e minacce anche per la nostra piccola collettività paesana.
L’agricoltura, per esempio, che è uno dei nostri settori più importanti si sta già confrontando con i cambiamenti climatici, prima fra tutte la quantità e la distribuzione nel corso dell’anno delle piogge, che richiede interventi tempestivi sia per preservare le nostre specie agricole sia per mantenere la produttività dei nostri terreni.
Nuove opportunità si aprono anche nei settori energetici, delle tecnologie dell’informazione, ambientale e, anche, nei settori delle opere pubbliche relativamente alla necessità di realizzare le opere di mitigazione per gli eventi meteorologici estremi. Per cogliere queste opportunità è necessaria una mentalità orientata all’innovazione e un approccio sinergico fra il settore produttivo e il mondo della ricerca pubblica e privata, in un ambiente sociale sano in cui i governi locali, nazionali e sovranazionali creino le condizioni migliori per poter operare in serenità con efficacia ed efficienza, in un sistema commerciale competitivo globalizzato dove, purtroppo, non tutti i giocatori, giocano con le stesse regole.